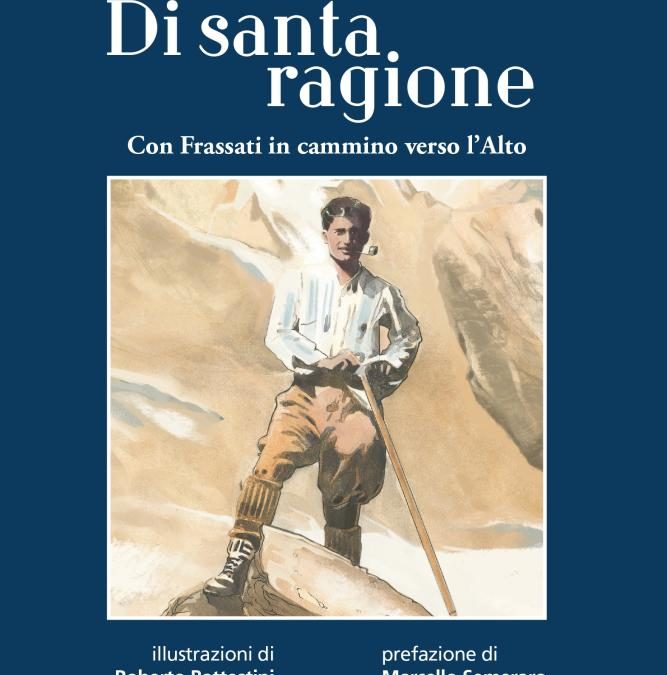Lazzati sulle orme di Frassati. Un libro
Nel chiudere la prefazione al bel volumetto Di santa ragione. Con Frassati in cammino verso l’alto (Settore giovani di Azione cattolica – Ave, Roma 2025), che raccoglie sette storie di vite giovanili, a vario titolo rapportatesi con quella del beato torinese, il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, ne cita la commemorazione tenuta, nel cinquantesimo della morte, da Giuseppe Lazzati (Torino, Palazzo Madama, 5 aprile 1975), su invito della Regione Piemonte. L’assegnazione dell’incarico non aveva nulla di estemporaneo. Pier Giorgio, infatti, fu figura nota e stimata da Lazzati sino dagli anni della gioventù.
L’attraente sorriso
Figlio di Alfredo, co-fondatore, poi direttore, de “La Stampa” di Torino, nonché senatore (liberale-giolittiano) del Regno, Pier Giorgio Frassati era nato il 6 aprile 1901; la nascita di Lazzati, milanese, risaliva invece al 22 giugno 1909, quarto di otto tra fratelli e sorelle, in una famiglia di commercianti nel settore caseario. Avevano, quindi, otto anni di differenza.
Iscritto nel 1921, da ginnasiale, all’Associazione studentesca Santo Stanislao, Giuseppe Lazzati fu assiduo a uno dei momenti “forti” della proposta associativa: gli Esercizi spirituali, secondo la tradizione gesuitica. Nella primavera del 1928 vi partecipava per la settima volta, presso Villa Sacro Cuore, a Triuggio (oggi provincia di Monza-Brianza).
L’esercitando, nel quadernetto di appunti, scriveva: «Qui sul tavolino mi sorride il volto buono, dall’espressione maschia di una volontà ferrea, dal sorriso puro che esprime tutta la gioia della vita cristianamente intesa e vissuta, di Pier Giorgio. Ne ho letto la vita, e ho sentito partire da lui un fascino che mi attraeva; l’ho visto circondato dall’aureola magnifica dell’eroismo, che è superamento quotidiano di sé, che è dedizione intera di sé alla carità di Cristo».
Prossimo alla laurea in Ingegneria, Frassati morì, ventiquattrenne, il 4 luglio 1925, stroncato da una fulminante meningite virale. Il salesiano don Antonio Cojazzi, celebre agiografo, nel 1928 ne pubblicò la prima biografia (Società Editrice Internazionale, Torino). Lazzati la lesse, non sappiamo se poco prima o durante gli Esercizi del medesimo anno: fatto sta che i giorni di ritiro a Triuggio furono, per così dire, in costante “compagnia” del giovane torinese, mostrando profonda ammirazione per lui e le sue virtù eroiche, con in cima la carità verso i poveri. «Anch’io voglio seguire il suo esempio», notava nel quadernetto. In tal modo, fedeltà ai doveri quotidiani, ossequio amoroso della volontà di Dio, testimonianza «leale e schietta della religione», della gioia cristiana e del servizio concreto ai fratelli, divennero per il giovane Lazzati proponimento fermo di una vita credente, ora illuminata pure dal fascino di Pier Giorgio.
Amico e “modello”
A conferma di quanto l’“incontro” del 1928 con Frassati fosse divenuto rilevante nel cammino umano e spirituale di Giuseppe Lazzati, basti qui dire che il suo ricordo tornava nei successivi Esercizi. «Io non posso levarmi dagli occhi la figura di Pier Giorgio», notava negli appunti del 1929. Poi aggiungeva: «Sento ora che quello che vado proponendomi non è se non la pratica della vita di Pier Giorgio ventenne. E io lo invoco sopra di me, perché mi aiuti a camminare in questa via, nella quale era tanto avanti». Analogo il tenore di altri richiami negli anni seguenti.
Dunque, Frassati come amico e “modello” cristiano per il giovane Lazzati. E tale rimase anche nel prosieguo della sua esistenza, notoriamente attraversata da “bufere” tremende (l’internamento nei campi di concentramento tedeschi), cui fecero seguito vicende e incarichi di alta responsabilità (dall’impegno politico post-bellico, Costituente compresa, alla guida dell’Università Cattolica).
Non sorprende allora che, a motivo della nota consonanza umano-spirituale con la figura di Pier Giorgio, nel 1975, i promotori della citata commemorazione si rivolgessero proprio a Giuseppe Lazzati, ora Rettore dell’Ateneo del Sacro Cuore. Egli aderì di buon grado, potendo fruire anche di materiali e documenti trasmessigli dalla sorella di Pier Giorgio, Luciana; documenti nei quali la personalità del fratello, oltre ai tratti spirituali-apostolici già messi in evidenza da don Cojazzi, poteva emergere nell’interezza del suo profilo umano, contrassegnato pure da un vigoroso sentire politico, che l’aveva indotto ad aderire al Partito Popolare di don Sturzo e ad assumere, nel medesimo tempo, una netta posizione antifascista.
Fede intrepida e cuore magnanimo
Pertanto, la relazione di Lazzati poteva tracciare un’immagine a tutto tondo del giovane torinese. La sua umanità, innanzitutto, colma di vitalità fisica, d’intelligenza aperta alla verità e alla bellezza, di prorompente senso dell’amicizia, di sensibilità delicata verso i bisognosi. Su questa struttura umana, già mirabilmente dotata, il relatore mostrava come la Grazia, assecondata dalla docilità di Pier Giorgio, operasse per fare di lui la bella persona, di fede intrepida e di cuore magnanimo, che tutti, anche alla luce della documentazione via via reperita, potevano ormai conoscere e ammirare nella sua totalità.
Un punto, fra gli altri, colpiva il Rettore, perché congeniale con la propria visione del cristiano laico: ossia, la volontà, in Pier Giorgio, di rendere l’auspicata professione d’ingegnere minerario, che l’avrebbe posto a contatto con lavoratori in condizioni difficili, il “luogo” e lo “strumento” privilegiato della propria testimonianza cristiana.
Giuseppe Lazzati vi ravvisava quasi un’anticipazione di Lumen gentium 31, il passo della Costituzione conciliare, che assegna ai fedeli laici, quale propria vocazione, la ricerca del Regno di Dio, «trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio». A suo dire, ciò confermava l’attualità dell’esperienza umana e spirituale di Pier Giorgio. Egli, pertanto, anche nella difficile stagione del post-Concilio, poteva essere additato come “modello” per il giovane cristiano e, più in generale, per ogni fedele laico.
Qui il punto di raccordo con la Prefazione del card. Semeraro, convinto che l’esemplarità laicale di Frassati brilla di nuova luce, se riconsiderata nella scia del Vaticano II. Purtroppo ‒ sembra di leggere fra le righe del presule ‒, il magistero conciliare in materia di laicato (a parte Azione Cattolica, Fuci e poco altro), ormai pressoché misconosciuto, risulta largamente disatteso.
Dopo la lectio del cinquantenario, Lazzati ebbe altre occasioni per tornare sulla figura di Pier Giorgio e la sua attuale esemplarità. Comprendiamo perché, giunto a conoscenza del grave rallentamento della Causa di canonizzazione, il 10 maggio 1975 si premurasse di scrivere a Paolo VI. Con la consueta deferenza, non disgiunta da familiare franchezza, osava chiedere al Papa di sollecitare la conclusione del processo romano di beatificazione di Frassati, persuaso che la sua elevazione alla gloria degli altari avrebbe potuto essere motivo di «grande bene» per molti giovani.
Di sicuro, la lettera di Lazzati non rimase senza effetti. La ripresa dell’iter per la Causa procedette spedita. Com’è noto, dopo la sua conclusione e la dichiarazione dell’“eroicità delle virtù”, il 20 maggio 1990, riconosciuta, per intercessione del giovane torinese, la miracolosa guarigione del friulano Domenico Sellan, Giovanni Paolo II proclamava Pier Giorgio beato. Il 7 settembre prossimo sarà la solenne conclusione del lungo percorso. Leone XIV, infatti, dopo l’attestazione del suo ruolo di “protagonista” in un altro miracolo, lo proclamerà santo, insieme all’adolescente milanese Carlo Acutis. È bello che il Settore Giovani di Ac concorra a onorare l’evento anche tramite la citata pubblicazione: Di santa ragione. Con Frassati in cammino verso l’alto. Un testo che si legge con sicuro profitto.