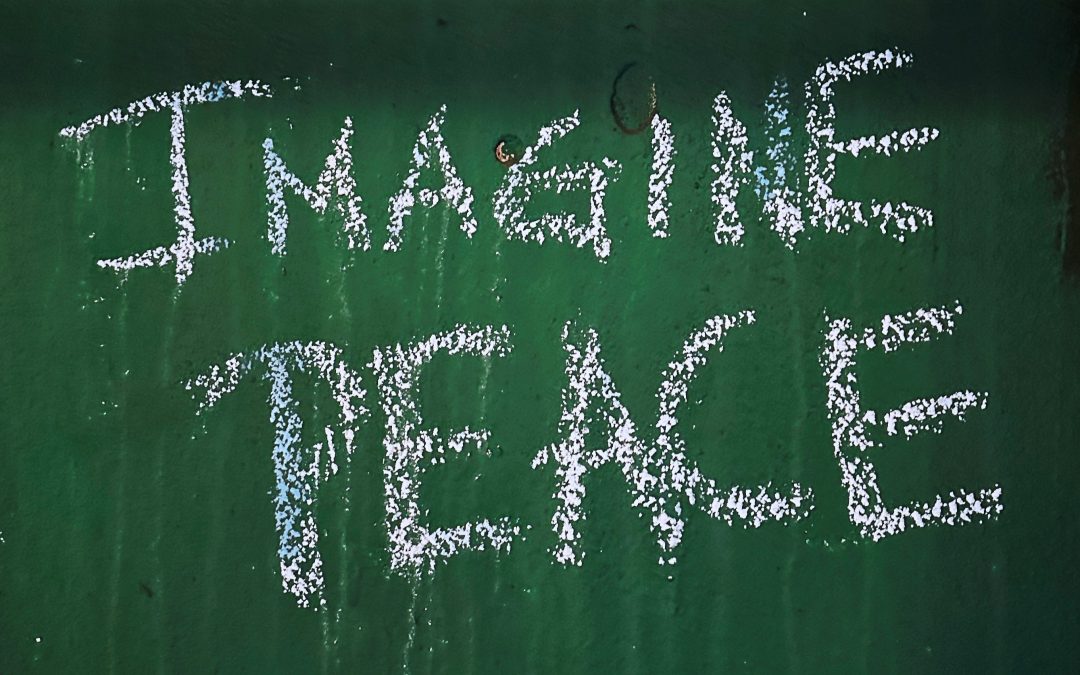difesa e riarmo Europa
Da tempo leggo prese di posizione anche di nostri cari amici sul problema della guerra e della pace in Ucraina, con quello che dietro si trascina. Oggi in particolare la questione del riarmo dell’Europa o, meglio, degli Stati europei. Per lo più apprezzo la sensatezza e la profondità dei rilievi. Ma qualche aspetto, non secondario, mi lascia perplesso.
difesa e riarmo Europa
Difesa e riarmo non coincidono
La difesa non è equivalente al riarmo e quello della von der Leyen è veramente riarmo. Ma il riarmo non è l’unica difesa. Non è quella tipica dell’Europa del nostro tempo, che ripudia la guerra non solo per via di principi costituzionali, ma anche per via di sentire culturale e antropologico: chi è disposto oggi in Europa a farla in prima, e non per interposta, persona? La difesa dell’Europa come entità voluta dai fondatori dopo la guerra primariamente puntava sulla creazione di scambi di conoscenza e di cultura e di commercio con una multiformità di aree (il poliedro di papa Francesco), che ci fa guardare in faccia l’altro e presentarci in faccia all’altro e gli fa dire che il rapporto pacifico è migliore anche per lui. Si è pensato prima di tutto ad una difesa fatta di convivenza operosa, di ragione e di cultura. La difesa alla von der Leyen punta sulla deterrenza, questa invece sulla amicizia dei popoli. È questa seconda che ha fatto cadere i blocchi contrapposti, non certo la deterrenza, perché ha sgretolato una mentalità bellicista. Mentre una revanche bellicista (sia da Ovest sia da Est: sì, da entrambe le parti, e non si sa chi prima) fa risorgere le contrapposizioni.
difesa e riarmo Europa
La deterrenza e le sue contraddizioni
Ma anche restando dentro l’orizzonte della deterrenza in armi, la difesa alla von der Leyen è inefficace ed impossibile. 1. Perché ci vogliono decenni prima che l’Europa (chi in Europa?) raggiunga una competitività bellica in grado di deterrere aree che l’hanno raggiunta gradualmente in tempi in cui la deterrenza era regola. Ora deterrenza vorrebbe dire saltare i gradini e andare subito alla deterrenza annientatrice. 2. Perché tutti evidenziano la difficoltà, anche tecnica, al limite della impossibilità, di coordinare le difese di un’Europa politicamente divisa, e questo inficia in radice la capacità di deterrenza militare. 3. Perché solo un pazzo oggi potrebbe voler conquistare con la forza il mondo col rischio di restare nel deserto o di perire con il mondo, e proprio perché è pazzo, non si lascerebbe comunque deterrere. 4. Essendo impossibile e inefficace, questa piccola deterrenza produrrebbe esibizioni di forza, ad uso interno dell’Europa, ostacolando decisioni comunitarie invise a qualche piccolo detentore di deterrenza, favorendo un’ulteriore escalation bellicista ad uso interno. O ci sentiamo tanto sicuri se si armano Germania e Polonia (tanto per dire…) invece che Usa e Russia e Cina? Meglio allora inserirsi casomai in un sistema difensivo già esistente e aduso alla responsabilità del rischio globale per aprirlo sempre più al rapporto, rendendolo sempre più culturale e meno dipendente dalle armi; sempre più Onu, sempre meno Nato e sempre più Europa multilaterale e sempre meno Europa vassalla. 5. Se non c’è una fraternità umana creata dal dialogo, la deterrenza bloccherà la guerra solo fino a quando una potenza crede di non essere tanto superiore da poter infischiarsene. E quando crede di sopravanzare l’altro, è tentata di sfruttare il vantaggio.
Dire che la difesa per riarmo spreca le risorse che potrebbero essere impiegate a servizio dell’umanità non è argomento facilmente liquidabile come demagogico. Lo spreco di risorse a vantaggio della forza cambia le priorità dei fini dell’umano; discrimina gli esseri umani tra di loro e li rende più conflittuali; crea uno spirito di rivalsa e fomenta la ricerca di un benessere per via di prepotenza.
Guerra e pace: oltre la superficie
Il dibattito nel Pd: ben venga discutere su questioni serie!
Siamo perciò oltre la Schlein; ma in questo caso solidarizziamo con la Schlein, e la compiangiamo perché sempre più ci convinciamo che si è sobbarcata ad una mission impossible. Ora la si accusa di non aver saputo gestire la spaccatura dentro il Pd: come se già non ci fosse. Se Tertulliano diceva: Quid ergo Athenis et Hierosolymis?, “Che c’è di comune tra Atene e Gerusalemme”, potremmo dire. Che c’è in comune tra Gori e Tarquinio? Ma noi diamo ad Ellly Schlein l’onore delle armi (che non ha votato) proprio perché è riuscita almeno a fare emergere una spaccatura su un problema fondamentale di etica politica dentro il PD. Che ci si divida su cose serie, alfine! E se ne renda ragione. O sarebbe forse stato meno scandaloso – come al dire degli Zanda perenni – se un partito fosse stato compatto, magari votando per il sì? Ché, in caso contrario, si sarebbe spaccato ancor più drasticamente. Comunque sia, la Schlein ha corso il rischio perché l’unità di un partito vale meno delle sorti del mondo.
Mi meraviglio infatti che in casa nostra non si faccia il dovuto riferimento al magistero di papa Francesco, che non perde occasione di sostenere che la corsa all’armamento è causa non effetto delle guerre. Zufola? Parla forse d’altro? O tratta del “caso serio”? O vogliamo liquidare il pensiero del papa pensando che a noi competa una mediazione politica che un papa, e malato, non può permettersi (“Lui deve dire così”)? Vogliamo almeno prenderlo in seria considerazione nei suoi risvolti storici, come sempre noi siamo stati abituati a fare, e cercare di capirne il senso? Tanto più che su questo punto i papi di questi due ultimi secoli, pur così teologicamente e culturalmente e antropologicamente diversi, l’hanno pensata allo stesso modo. Vorrà dire qualcosa; o no?