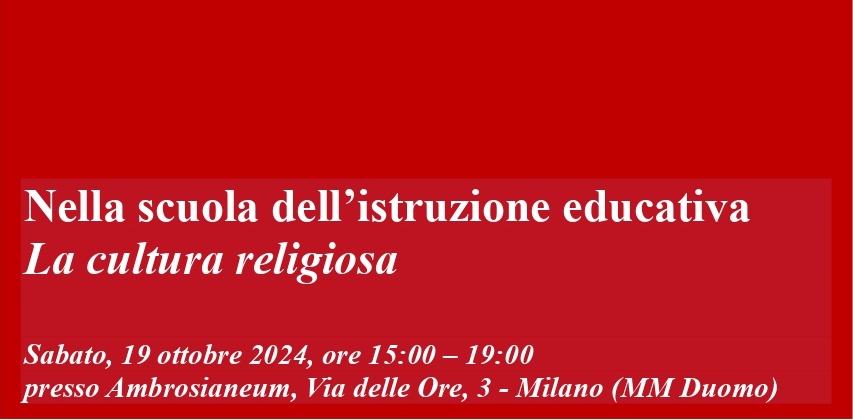Sabato, 19 ottobre (ore 15-19)
La Città dell’uomo Aps e l’Associazione Agire politicamente promuovono il Convegno: Nella scuola dell’istruzione educativa. La cultura religiosa.
Alle relazioni di P.C. Rivoltella (Università di Bologna), Quando la relazione è muta. Sfide e tentazioni della scuola di oggi, e L. Prenna (Coordinatore di Agire politicamente), Educare istruendo. Un’idea di scuola seguirà una Tavola rotonda su La cultura religiosa. Oltre la marginalità, coordinata da R. Osculati (vicepresidente Consiglio comunale di Milano), con interventi di R. Andronache (Comunità ortodossa romena), T. Cera (insegnante di Religione cattolica), D. Di Carlo (pastora Chiesa Valdese, Milano), A. Mahmoud (presidente Casa della cultura di via Padova, Milano).
Il Convegno muove da un inquadramento generale della scuola odierna, con particolare riguardo alla comunicazione/relazione all’interno e all’esterno di essa, ponendo altresì attenzione alle prevalenti logiche d’intervento ministeriale per far fronte ai problemi insorgenti. La riflessione si appunterà, quindi, sul modo specifico di educare da parte della scuola, che passa attraverso l’istruzione, ossia l’incontro nel processo d’insegnamento/apprendimento con la cultura, in tutta l’ampiezza dei suoi significati. Mediante la dimensione culturale, veicolata dalle singole materie nel rispetto dei livelli psico-evolutivi personali, l’alunno/studente è progressivamente introdotto nella conoscenza della “realtà totale”. Fra le numerose forme di codificazione storica della cultura, il Convegno richiama l’attenzione su quella religiosa. Essa, in una scuola sempre più pluralistica e proprio per questo bisognosa di specifica cura per componenti socio-formative fondamentali, quali
l’inclusione e la capacità di dialogo inter-personale, può assolvere un ruolo significativo. Ci sembra però che la modalità d’inserimento della cultura religiosa nei curricoli scolastici, allo stato attuale, rimanga alquanto lacunosa. In ogni caso, meritevole di un pacato dibattito civile. È quanto ci proponiamo anche con il nostro incontro.
Luciano Caimi
(presidente di La Città dell’uomo)
Locandina del Convegno scaricabile qui
Qui riportiamo l’introduzione preparata da Luciano Caimi
Introduzione Convegno “Nella scuola dell’istruzione educativa. La cultura religiosa”
Ambrosianeum, 19/10/2024
La scuola ci sta a cuore. Dove il ci pronominale riguarda tutti i presenti in sala.
Alle Associazioni promotrici del Convegno, La Città dell’uomo e Agire Politicamente, la scuola sta a cuore anche per il suo profilo politico, inteso in senso costituzionale e istituzionale.
La scuola è istituzione al centro della nostra Costituzione, sebbene non siano molti i passaggi del testo ad essa espressamente dedicati. È al centro perché i Padri e le Madri costituenti ebbero ben chiaro il ruolo insostituibile del processo d’istruzione/formazione per promuovere la figura di uomo e donna cittadini democratici, in grado di concorrere all’edificazione della “Casa comune”, identificativa della nuova Italia tratteggiato dalla Carta.
Naturalmente, affinché questo fondamentale obiettivo possa essere perseguito, lo Stato si dota di una specifica struttura/apparato progettuale/gestionale: ecco il Ministero della Pubblica Istruzione, con le sue articolazioni territoriali. È l’organo di elaborazione ‒ sempre in progress ‒ delle linee generali di politica scolastica. Un lavoro mai “neutrale”, perché legato agli orientamenti dei Governi di volta in volta al potere. E siccome nessun Esecutivo è neutrale, non saranno tali nemmeno le opzioni operate. Per questo, La Città dell’uomo e Agire Politicamente cercano di tenere gli occhi ben aperti anche sulle politiche scolastiche, settore tutt’altro che secondario rispetto al problema politico-culturale nel suo insieme, di cui espressamente si occupano.
Ciò detto, s’impone subito una domanda: ma che cos’è e a che cosa serve la nostra scuola oggi? Ovvio attendersi risposte diverse, anzi molto diverse. Nessuna, però, mi sembra possa sottrarsi a tre sfide epocali.
La prima: siamo all’interno di un processo storico-culturale di radicale «cambio d’epoca» che investe paradigmi tradizionali a partire da quelli di carattere antropologico, con le ricadute sull’ethos individuale e collettivo. “Liquidità”, “fluidità”, “narcisismo” sono linee di tendenza della sensibilità odierna, ben ravvisabili anche nei nostri alunni/studenti. Il diffuso senso di disagio in non pochi preadolescenti, adolescenti e giovani esprime la loro fatica a trovare “coordinate” orientative e rassicuranti per il proprio cammino. Può la scuola reputarsi “neutrale” dinanzi a tale fenomeno?
La seconda sfida: si tratta della rivoluzione in atto con il prodigioso sviluppo delle tecnologie informatico/digitali, che, letteralmente, plasmano le nostre esistenze quotidiane. Per i millennials, il cosiddetto virtuale, ossia la “realtà aumentata”, è sì ricco d’inedite opportunità e modalità conoscitive, relazionali, comunicative, ma il rischio che l’intreccio spasmodico di collegamenti e legami in rete li avvolga in una “bolla autoreferenziale”, con aperture interne, senza però porte e finestre sull’esterno, è altrettanto reale. Di fatto, il reticolo social ha ormai definito anche una nuova grammatica comunicazionale. Con evidenti ricadute sui processi di insegnamento/apprendimento.
La terza sfida: è rappresentata dal profilo sempre più plurale della nostra società. Pluralità di etnie, lingue, costumi, religioni. L’impatto dell’immigrazione sulla scuola, con le relative questioni concernenti l’aspetto linguistico, i contenuti del curricolo, la composizione delle classi, è sotto gli occhi di tutti. Questa situazione può essere vissuta ‒ e, purtroppo, lo è anche da parecchi insegnanti ‒ come condanna. Ma, se bene interpretata, può diventare una sorta di kairos, condizione e tempo propizi per percorsi intelligenti orientati alla realizzazione di una «convivialità delle differenze». In tale maniera, l’aula scolastica può davvero costituirsi come piccola, ma significativa esperienza di profezia per un modello di socialità applicabile su larga scala.
A questo punto, proviamo a identificare il filo conduttore del Convegno.
Il prof. Pier Cesare Rivoltella ci offrirà, da par suo, una linea interpretativa del quadro d’insieme della nostra scuola, raccogliendola intorno alla categoria cruciale della relazione, che ritiene però muta. Saranno allora da scoprire senso e direzioni di tale mutismo o afasia relazionali, che rischiano d’invalidare la natura profonda della scuola, casa del logos, cioè della parola e, quindi, del dialogo, interpersonale e interistituzionale. Un ambiente scolastico relazionalmente muto, anche se esteriormente chiassoso, menoma in radice la possibilità di essere luogo di genuina e integrale promozione di ciascun alunno/alunna, studente/studentessa.
Con l’intervento del prof. Lino Prenna il nostro itinerario convegnistico si focalizza sul modo specifico di educare da parte della scuola, che passa attraverso l’istruzione, ossia l’incontro nel processo d’insegnamento/apprendimento con la cultura, in tutta l’ampiezza dei suoi significati. Mediante la dimensione culturale, proposta in forma articolata e specifica dalle singole materie nel rispetto dei livelli psico-evolutivi personali, l’alunno/studente è progressivamente introdotto nella conoscenza della “realtà totale”.
Fra le numerose forme di codificazione storica della cultura, il Convegno richiama l’attenzione su quella religiosa. Essa, in una scuola sempre più pluralistica e proprio per questo bisognosa di specifica cura per componenti socio-formative fondamentali, quali l’inclusione e la capacità di dialogo interculturale, può assolvere un ruolo altamente significativo. Ci sembra però che, allo stato attuale, la modalità d’inserimento della cultura religiosa nei curricoli scolastici rimanga alquanto lacunosa. Oltre l’Irc c’è, praticamente, il nulla.
Esperti comparatisti del problema su scala internazionale ci dicono che la situazione italiana è più deficitaria anche rispetto a quella di paesi totalmente secolarizzati del Nord Europa. Sicché, molti studenti non avvalentisi dell’Irc, considerato il quasi totale fallimento della cosiddetta “ora alternativa”, rischiano di uscire dal ciclo scolastico senza un minimo di conoscenza onesta sulla grande storia, comunque la si giudichi, delle religioni nel cammino dell’umanità: incominciando dalle religioni del ceppo abramitico, che riguardano da vicino popoli e civiltà dell’area mediterranea, ancora una volta insanguinata da orrendi massacri.
Nessuno ha in tasca formule risolutive e facilmente applicabili. Però il tema mi sembra tale da meritare un pacato dibattito civile. L’intervento di Prenna e il confronto inter-religioso nella tavola rotonda ci potranno aiutare in tal senso.
(Luciano Caimi)