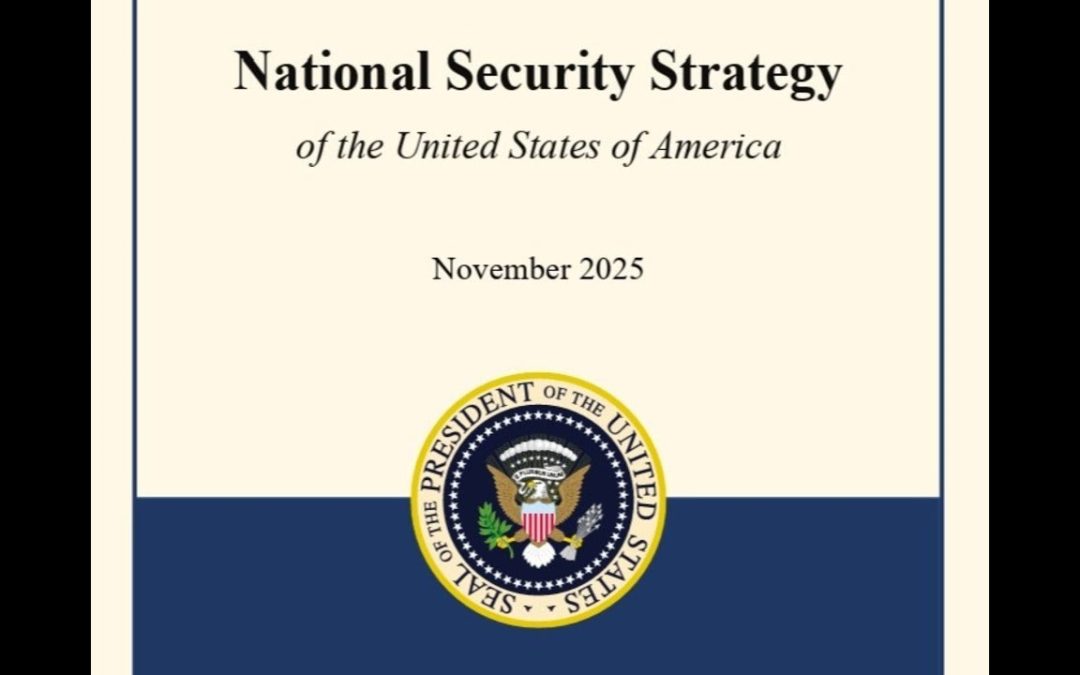La National Security Strategy 2025, appena pubblicata dall’amministrazione Trump, è un documento molto chiaro nella sua ispirazione ideologica (più che nell’obiettivo di spiegare in modo articolato una certa posizione nel mondo). Si centra infatti sulla scelta fondamentale di affermare la “sovranità” e quindi gli interessi nazionali degli Stati Uniti d’America (“il paese più forte, ricco e potente, più pieno di successo del mondo”). In questo senso, l’obiettivo della strategia nazionale dell’amministrazione in carica è semplice da descrivere: “vogliamo la continuazione, la sopravvivenza e la sicurezza degli Stati Uniti come una repubblica sovrana e indipendente, il cui governo assicura i diritti naturali dei suoi cittadini come dati da Dio e mette al primo posto il loro benessere e i loro interessi”.
Sviluppando questo discorso, è interessante notare che un mondo pacificato è descritto come positivo semplicemente perché i conflitti sono “negativi per gli interessi americani”. E poi si sostiene che “il mondo funziona meglio quando le nazioni mettono al primo posto il loro interesse”: magari gli Stati Uniti possono permettersi di spiegare agli altri quale sia il loro proprio vero interesse (come si fa poche pagine più avanti per l’Europa). Ma l’annotazione è comunque molto interessante, delineando un mondo che starebbe in equilibrio proprio nell’incontro delle logiche soggettive dei diversi nazionalismi (anche se temo sia una visione contraddetta dalla storia, perché evidentemente è difficile una qualche alleanza stabile e feconda o anche una convivenza pacifica tra ultranazionalismi). Come è indicativa l’affermazione successiva, per cui non c’è cosa peggiore che un “transnazionalismo che cerca esplicitamente di dissolvere la sovranità di ogni Stato”. Fin qui la Nss 2025.
Insomma, il quadro è chiaro: niente sopra lo Stato-nazione sovrano e i suoi interessi, che sono l’unico vero assoluto della storia. Questo “sovranismo”, come si usa dire con un neologismo diffusosi negli ultimi anni, è qui espresso nella sua forma più netta. Meriterebbe molte riflessioni, ma ci limitiamo a un aspetto. Hanno detto alcuni esperti che sia facile riconoscere nel testo la presenza particolare della penna di J.D. Vance, il cattolicissimo vicepresidente di Trump. Orbene: è possibile collegare questo approccio a qualche ispirazione cristiana? Si può sostenere che ci sia una coerenza con la fede, il catechismo, la dottrina sociale della Chiesa?
Temo sia molto difficile. Facciamo un discorso di grande sintesi, utilizzando qualche inevitabile schematizzazione. La nazione intesa in senso politico è un fenomeno moderno. Con cui la cultura cristiana ha costruito nel tempo un intreccio tutt’altro che banale. Non c’è mai stato nella storia della Chiesa universale, e men che meno in quella delle chiese particolari, un approccio antinazionale per principio. Anzi, la nazione come identità collettiva, come “mito” di una comunità esistente nel tempo con una propria base comune (storica, etnica, linguistica), è stata spesso considerata uno degli elementi “naturali” della convivenza umana che andasse valorizzata, protetta, amata. Lo dice anche il (relativamente recente) Catechismo della Chiesa cattolica (n. 2239: “L’amore e il servizio della patriaderivano dal dovere di riconoscenza e dall’ordine della carità”). Nella storia del cattolicesimo politico, sono amplissimi i segni della presenza di un sobrio patriottismo. Ogni nazione con una forte presenza cristiana ha visto crescere una cultura della missione nazionale con agganci esplicitamente religiosi (magari diversamente accentuati, secondo le diverse confessioni cristiane). Nel caso dell’Italia, una visione “guelfa” dell’Italia – la “nazione cattolica” per eccellenza – ha dominato la coscienza del cattolicesimo nazionale per due secoli.
Ma da qui a sostenere il “nazionalismo”, nel senso preciso dell’espressione in lingua italiana, cioè la dottrina della preminenza assoluta della propria nazione sulla altre, in una concezione conflittuale di contrapposizione tra le nazioni, ce ne corre ovviamente moltissimo. I papi del Novecento si sono sgolati contro i nazionalismi “immoderati”, contro il rischio che la fede cieca nelle patrie rispettive oscurasse il senso della comune umanità. Si pensi alla vera e propria fatica di Benedetto XV a mettere in guardia verso un uso nazionalista della religione nel crogiolo della guerra mondiale, che aveva prodotto una sorta di sacralizzazione di una equivoca “religione della patria”. Al fatto che Pio XI prima di morire stava preparando un’enciclica dedicata fin dal titolo alla “Humani generis unitas”. E potremmo moltiplicare le citazioni. Anche i politici credenti lungo il Novecento hanno sempre inteso la valorizzazione della propria nazione all’interno di una “comunità internazionale”, con la necessità di contemperare i progetti di affermazione dei propri interessi all’interno di una convivenza regolata, che avesse come obiettivo costruire una pace giusta e umana. Molteplici sono le conseguenze di questa impostazione, che ha potuto anche nutrire singole scelte politiche diverse, ma si è sempre assestata su una logica universalistica di principio.
Papa Francesco ha recentemente portato un grosso contributo in questa direzione quando nella “Evangelii gaudium” ha riflettuto sul rapporto tra conflittualità e unità: “l’unità prevale sul conflitto”, non negandolo, ma costruendo vie per superarlo, nella logica di “sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo”, EG 227)). E nella “Fratelli tutti” ha proposto la necessità della convivenza tra le comunità umane in una logica non di appiattimento e di annullamento delle differenze, ma di convivenza capace di valorizzare il pluralismo e appianare le divergenze. La globalizzazione non deve appiattire, ma collegare: «l’universale non dev’essere il dominio omogeneo, uniforme e standardizzato di un’unica forma culturale imperante” (FT 144). Ricordiamo tutti il teorema del “poliedro”, contrapposto alla sfera.
Le nazioni, vivaddio, possono senz’altro esistere ed essere momenti di identificazione degli esseri umani dotati di qualche significato. Ciascuno può essere e sentirsi felicemente italiano o statunitense o malese o mozambicano: ma il tema è che semplicemente le nazioni non sono assoluti. Vanno demitizzate. Il “prima noi” va evitato come la peste. Infatti, riflette san Paolo, «non c’è giudeo né greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo» (Gal 3,28). Nella comune creaturalità, è comune anche la fonte della redenzione.
Ricorriamo a uno dei grandi spiriti cristiani del Risorgimento italiano, Alessandro Manzoni, che nelle Osservazioni sulla morale cattolica scriveva, due secoli orsono: “Bisogna sentire e ripetere che la somiglianza che ci dà l’essere d’uomo, è ben più forte che la diversità di nazione, che il Vangelo ci ha fatto conoscere che abbiamo un cuore grande abbastanza per amar tutti gli uomini, che gli sforzi di una nazione contro l’altra quando non sieno necessarj sono sempre piccioli, perché fondati sulle passioni, e non sulla ragione e sulla verità; sono inutili, perché non ottengono stabilmente nemmeno il fine che si propongono quegli che gli fanno; sono impolitici, perché producono spesso all’istante, e sempre nell’avvenire l’indebolimento e il pervertimento dei popoli”.
Quindi, non è difficile ragionare sul fatto che – inteso in questo modo – l’universalismo e l’antinazionalismo, nella loro stretta connessione, costituiscano un vero e proprio “principio non negoziabile” della fede cristiana. Rispolveriamo questa formula un po’ desueta e affermiamolo a chiare lettere.