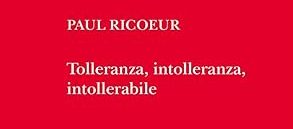La tolleranza riveste un ruolo fondamentale per la convivenza associata, a tutti i livelli. Un concetto le cui origini risalgono all’antichità classica, poi venuto affermandosi attraverso l’elaborazione dell’umanesimo, successivamente consolidatosi nel corso della Riforma protestante. Esso ha trovato una compiuta sistematizzazione nel pensiero illuministico, soprattutto in Voltaire e John Locke che hanno visto nella tolleranza un valore essenziale per la libertà del soggetto, la coesistenza pacifica, lo stesso progresso sociale. Una acquisizione, dunque, che, sviluppatasi in ambito religioso, assume un’importanza basilare per la vita civile, tornando spesso al centro della riflessione filosofica. In particolare, Paul Ricoeur, uno dei principali esponenti di quella corrente di pensiero che si è mossa tra fenomenologia e ermeneutica, ha dedicato alla tolleranza approfondimenti oggi in parte proposti in un agile volumetto – Tolleranza, intolleranza, intollerabile – edito dalla Morcelliana con una breve, ma densa nota del curatore Ilario Bertoletti.
Ricoeur prende le mosse dal contesto storico entro il quale la tolleranza viene affermandosi, vale a dire da quando lo Stato e la politica non chiedono più l’unzione sacra alla gerarchia religiosa e quest’ultima, a sua volta, non ricorre al braccio secolare per ottenere una sanzione punitiva nei confronti dello scisma e dell’eresia: la fine dell’idealtipo “una fede, una legge, un re”, cui se ne sostituisce un altro retto sul principio del non interdire e sul riconoscimento della libertà che risulta, appunto, dall’astensione dell’interdizione. Lo studioso procede quindi alla disamina delle tre giustificazioni su cui fonda la tolleranza. Anzitutto quella politico-giuridica, istituzionale che si regge sulla giustizia come uguaglianza dinnanzi alla legge e su procedure che mirano a limitare gli svantaggi degli sfavoriti. Una giustizia che non è il tribunale della verità, così come il potere non ne è il detentore.
La seconda giustificazione è di tipo culturale, come esito di una confluenza di valori propri della tradizione laica e di quella di ispirazione cristiana che rifiutano la violenza insita in forme dogmatiche di convinzione. Ne scaturisce un “consenso conflittuale”, in quanto “i due fiumi della modernità hanno non solo sorgenti diverse, ma conservano un corso diverso”, pur accordandosi su valori condivisi. Infine, la giustificazione di matrice teologica, riconducibile al rifiuto della violenza nella testimonianza di fede, all’“unità plurale dei Vangeli”, alla restituzione al nome di Dio della sua alterità – una alterità che offre spazi d’incontro – , nonché al riconoscimento di molteplici modi di comprendere il “Grande Codice” del sacro.
In quanto rinuncia ad interdire, inoltre, la tolleranza è frutto di una ascesi che procede per diversi stadi: dalla sopportazione di ciò che si disapprova allo sforzo di comprensione di modi di vivere che si devono accettare pur senza aderirvi, al rispetto del diritto altrui di esprimere la propria volontà di vivere a proprio piacimento manifestandola pubblicamente, al riconoscimento di diversità che dicono di un rapporto al bene di non immediata decifrazione, sino allo stadio finale che consiste nella legittimazione della pluralità umana nell’approvazione “di tutte le maniere di vivere purché non nuocciano esplicitamente a terzi”.
A questo punto Ricoeur, che sente di dover mettere in guardia dalla tolleranza come indifferenza e da una sua declinazione nichilistica, si interroga sull’intollerabile, vale a dire sull’abbietto “indegno di rispetto perché esso stesso senza rispetto”, nonché sulla pulsione del potere politico alla pretesa della verità. Da qui il suo appello all’indignazione, alla collera morale come passione reattiva. Con una duplice avvertenza: anzitutto il primo intollerabile è l’intolleranza, in secondo luogo il dovere della responsabilità verso il “fragile” in tutte le sue molteplici forme. Infine, rifacendosi a John Rawls che si interroga sui presupposti morali ai quali i principi di giustizia da lui elaborati dovrebbero fornire un’argomentazione razionale, Ricoeur evoca l’impegno a “convinzioni ben ponderate”, ad un “equilibrio riflessivo” al fine di evitare che l’indignazione sfoci in comportamenti tali da entrare in conflitto con l’una o l’altra libertà pubblica, a partire da quella di espressione.