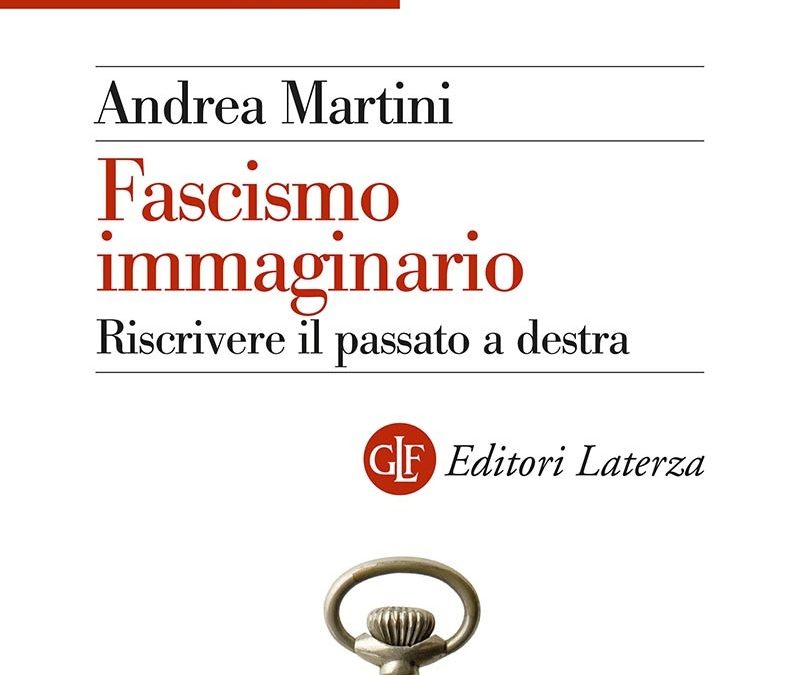Una comunità di perseguitati, vittime di un’epurazione selvaggia, estromessi dalla vita pubblica: è questa la raffigurazione di sé che i fascisti post 1945 propongono per descrivere la propria condizione nell’Italia repubblicana. Quanti insomma non solo non rinnegano la propria adesione al movimento fondato da Mussolini, ma esaltano il passato regime sino alla militanza nel Msi. Una raffigurazione avvalorata da quegli studiosi che parlano di “esuli in patria”, vale a dire di emarginati cui sarebbe stato impedito di svolgere un’attività politica o culturale che non fosse periferica. E pur tuttavia come documenta un giovane, ma già affermato studioso, Andrea Martini, nel suo “Fascismo immaginario”, sin dagli anni dell’immediato secondo dopoguerra è operante in Italia una comunità volta ad elaborare una “memoria nera”, un’ “altra memoria” e a riscrivere il passato costituito dal Ventennio e dalla guerra civile, mettendo in circolazione versioni dei fatti che propongono appunto un “fascismo immaginario”, mai esistito, scostato dalla effettiva realtà storica. Non solo un fascismo “che ha fatto anche cose buone”, ma la difesa del regime e della Rsi ad opera di epigoni che a volte si mimetizzano, a volte rivendicano con orgoglio la propria biografia, oscillando tra omissioni e falsificazioni e incontrando una significativa platea di lettori.
Infatti, al contrario di quanto avviene in Francia e Germania, sugli scaffali delle librerie compaiono memorie, romanzi, saggi critici, biografie così come sui giornali e riviste articoli ed editoriali che non esitano a rileggere in chiave agiografica e indulgente, sino alla assoluzione se non addirittura alla esaltazione, il recente passato. Una pubblicistica che non trova ostacoli alla propria propagazione, che si avvale del supporto di case editrici tanto di modeste dimensioni -da Cappelli a Vallecchi- quanto ampiamente affermate quali Bompiani, Garzanti, Mondadori, Rizzoli, le quali, o per sfruttare opportunità di mercato o appellandosi ad una presunta neutralità, si fanno veicolo di una amplificazione di topoi ricorrenti : Mussolini una figura geniale e coraggiosa, la Rsi al servizio di un disegno volto a tutelare gli italiani dalla presenza nazista, il fascismo come compimento della storia d’Italia, la rimozione della violenza squadristica esercitata nella lotta politica, le differenze tra Hitler e Mussolini, l’antisemitismo fascista come fenomeno di scarso rilievo, la partecipazione dell’Italia alla guerra dovuta e inevitabile, il Duce come figura affascinata dalle suggestioni cristiane, l’identificazione tra patriottismo e fascismo e l’appello alla pacificazione, la polemica contro l’antifascismo. Questa la gamma di temi su cui si esercita negli anni della ricostruzione e oltre “l’inchiostro nero”, schierato “dalla parte dei vinti” e contrario alla “storia scritta dai vincitori”, secondo il motto di un personaggio emblematico come Leo Longanesi sempre alla ricerca di pubblicazioni provocatorie ed eccentriche per la sua casa editrice, sino al punto da dare alle stampe il memoriale di Amerigo Dumini, uno degli assassini di Matteotti, che accusa la magistratura di persecuzione nei suoi confronti.
Sotto la lente di ingrandimento di Andrea Martini scorrono scritti di giornalisti – da Concetto Pettinato a Ermanno Amicucci, da Bruno Spampanato a Giovanni Tonelli a Mario Tedeschi – , di esponenti di primo piano del regime – Giuseppe Bottai e Rodolfo Graziani – , di biografi di Mussolini – Giorgio Pini e Yvon De Begnac – , di “storici” – Giorgio Chiurco, Giorgio Pisanò, Edoardo e Duilio Susmel –. A quest’ultimo Martini dedica un intero, illuminante capitolo – è stato curatore dell’opera omnia di Benito Mussolini in 36 volumi e 8 di appendici –, esaminando con particolare attenzione i suoi rapporti, ora cordiali ora critici, con Renzo De Felice. Duplice l’impressione che si ricava a conclusione della lettura: da un lato un’Italia democratica e tollerante sino a consentire la divulgazione di scritti volti a promuovere sul piano culturale e ideologico la continuità del fascismo, dall’altro lato un’Italia immemore di quanto esso ha rappresentato, nonché incapace di fare i conti fino in fondo con linee di pensiero spesso per altro assai vicine a quelle afasciste e anti- antifasciste oggi nuovamente all’ordine del giorno.