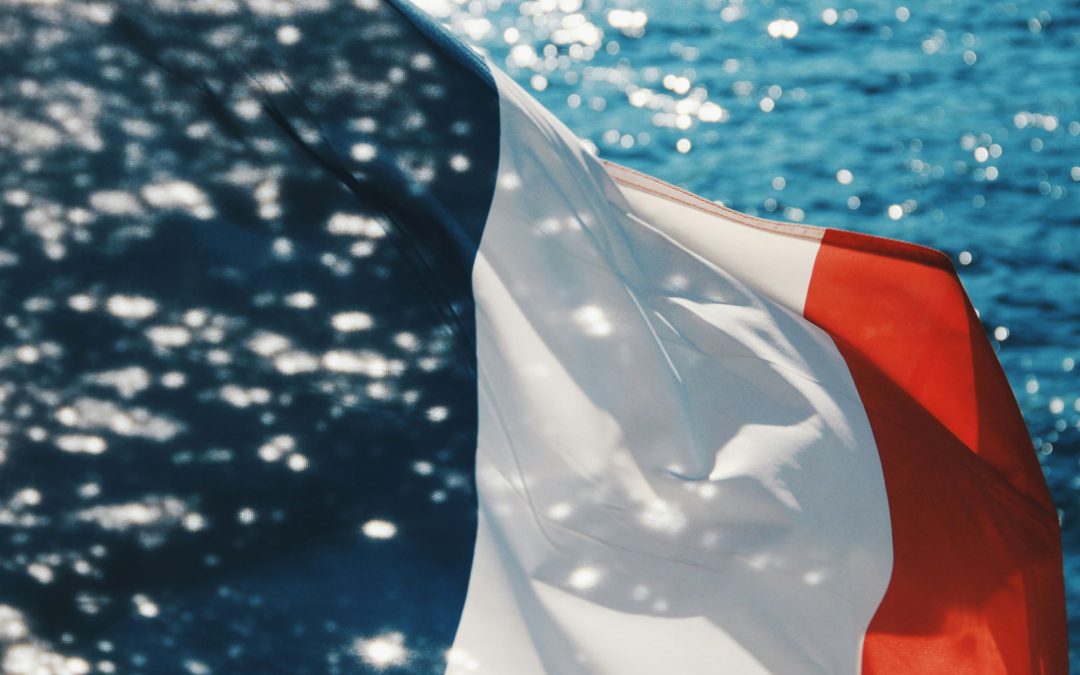È possibile superare la soluzione di stallo venutasi a creare in Francia? Ne sembra convinto il presidente della Repubblica Emmanuel Macron che nella tarda serata di venerdì 10 ottobre ha riaffidato l’incarico di primo ministro a Sébastien Lecornu compiendo un vero e proprio azzardo politico, l’ennesimo.
Nominato presidente del Consiglio già il 9 settembre, Lecornu, dopo settimane trascorse a incontrare le forze politiche dell’arco parlamentare, aveva annunciato domenica 5 ottobre la propria squadra di governo. L’indomani mattina, però, erano arrivate le sue dimissioni dato che alla lettura dei ministri che lo avrebbero dovuto affiancare, buona parte dei partiti che si erano ripromessi di appoggiarlo si sono scagliati contro di lui, reo di non aver lanciato un chiaro segnale di rottura con il precedente governo: troppe le personalità politiche in continuità con l’esecutivo Bayrou.
L’insistenza di Macron
Macron, tuttavia, non si è arreso e ha chiesto a Lecornu un ultimo sforzo: confrontarsi nuovamente con le forze politiche al fine di valutare se vi fosse ancora uno spiraglio per formare un governo evitando lo scioglimento del Parlamento. Questo spazio pare effettivamente esserci: a eccezione dei partiti alle due estremità dell’Assemblea nazionale – la France insoumise e il Rassemblement national (Rn) – sembra che buona parte dei partiti non ritenga opportuno (ed elettoralmente conveniente) recarsi nuovamente alle urne.
A questo punto Macron congeda Lecornu, che ha portato a termine il mandato esplorativo, e dopo aver convocato tutte le forze politiche contrarie a nuove elezioni per il pomeriggio di venerdì 10 ottobre (attraverso un’email trasmessa nel cuore della notte), alle 22 di quello stesso giorno scioglie le sue riserve e annuncia il nuovo primo ministro… il dimissionario Lecornu. Macron, insomma, pare sfidare le leggi della fisica, tornando indietro nel tempo, di fatto a quel famoso 6 ottobre quando l’esecutivo Lecornu doveva diventare a tutti gli effetti operativo.
Il presidente della Repubblica è tuttavia convinto del contrario, cioè che il contesto politico in apparenza immutato sia in realtà cambiato, grazie a una postura più aperta al dialogo manifestata da buona parte dei gruppi parlamentari. Lecornu stesso, nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, si dice fiducioso: l’esecutivo sarà composto da personalità non implicate nelle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2027, e questo, a suo dire, gli consentirà di disporre di una squadra di governo più votata a fare gli interessi del Paese piuttosto che quelli del proprio partito [Il y a aura un moment de vérité, «La Tribune dimanche», 12 ottobre 2025, p. 3].
Le prossime ore daranno più o meno ragione al duo Macron-Lecornu. Appare tuttavia evidente come la situazione politica francese sia così fluida che qualsiasi tentativo di restituire un resoconto dettagliato rischia, dopo poche ore, di apparire inattuale. Sottraiamoci dunque dalla missione impossibile di inseguire gli eventi.
Una Repubblica sotto attacco
Del resto, a prescindere dalle sorti del governo Lecornu, lo scenario francese, così come si è sviluppato fino ad ora, appare di grande interesse per chiunque si occupi di democrazia, per chi cioè la studia, per chi la difende nella quotidianità nelle vesti di attivista, per chi, infine, fa politica a livello locale, nazionale o internazionale. Se infatti il dibattito pubblico pare ruotare intorno al progetto di riforma delle pensioni avanzato dal governo Élisabeth Borne ancora nel 2023, un piano che ha diviso e continua a dividere i francesi (e i partiti che ne sono espressione), di fondo esso sempre più si interroga sull’efficacia del sistema “Quinta Repubblica” nel suo complesso, data la situazione di stallo venutasi a creare.
È inevitabile che anche la stessa Marine Le Pen si sia lanciata nel dibattito. In un’intervista rilasciata sulle colonne de «Le Journal du dimanche» del 21 settembre, la leader di Rn ha accusato Macron di aver riportato la Francia nell’immobilismo tipico della Quarta repubblica (un’immagine, in verità, parzialmente decostruita dalla storiografia), e ha promesso ai suoi elettori di battersi per riportare in vita la Quinta repubblica (sinonimo, secondo lei, di una politica che “decide” e che lo fa rapidamente). È lecito dubitare di questa difesa istituzionale di Le Pen. Nicolas Lebourg, tra i più importanti specialisti di estrema destra in Francia, non ha dubbi: il vero obiettivo di Rn sarebbe quello di condurre la Francia verso un corso illiberale [Le Rassemblement national comme un poison dans l’eau, «Libération», 9 ottobre 2025, p. 5].
Possiamo attribuire un peso più o meno importante alle parole di Marine Le Pen e possiamo cogliere nelle sue dichiarazioni intenti più o meno demagogici, ma la questione rimane: è la Quinta repubblica a essere in crisi o sono, semmai, i partiti presenti sulla scena politica che si dimostrano incapaci di comprenderla sino in fondo, dunque di fare politica entro i confini dettati dalle regole del gioco di una Costituzione approvata dai francesi nel lontano 1958?
Si pensi ad esempio allo scioglimento (dissolution) dell’Assemblea nazionale voluta dal presidente Macron nelle ore immediatamente successive le elezioni europee (9 giugno 2024), segnate dalla vittoria di Rn.
Tempi e modi della dissolution sono state oggetto di forti critiche. Essa viene proclamata in tarda serata e giunse all’indomani di un periodo elettorale intenso, imponendo di fatto ai partiti di impegnarsi in una nuova campagna, questa volta allo scopo di nominare i propri rappresentanti all’Assemblea. Eppure la mossa del presidente Macron rientrava nei poteri riconosciutigli dalla Quinta repubblica e si poneva come obiettivo quello di rendere più stabile l’Assemblea nazionale, rafforzando auspicabilmente, dal suo punto di vista, il numero di deputati “macronisti”. Vi aveva ricorso anche il presidente Jacques Chirac nel 1997 al fine di disporre di un Parlamento più stabile (e soprattutto di centro-destra): la scelta, anche in quel caso, si rivelò un fallimento, dato che le forze di sinistra prevalsero alle elezioni e il presidente fu costretto a inaugurare una stagione di coabitazione con un primo ministro di differente orientamento politico, il segretario del Partito socialista Lionel Jospin.
Ha ragione, insomma, lo storico del diritto François Saint-Bonnet quando, su un numero speciale di «Libération» uscito il 9 ottobre, afferma che lo scioglimento dell’Assemblea da parte di Macron, pur auspicando di essere una soluzione, ha finito per aggravare il problema. Ma ancora più condivisibile è la seconda parte del suo ragionamento, dove lo studioso sottolinea come la prima causa dell’instabilità politica non sia tanto da ricercare nella “dissolution alla Macron” bensì nella difficoltà della politica francese di confrontarsi con un contesto tripolare [De Louis XVI à Macron, la dissolution comme remède mirage, p. 6].
Tale frammentazione della vita politica francese non risale certo al 2024, ma le istituzioni ci sembrano averla sottovalutata per troppo tempo: ecco perché un nuovo scioglimento dell’Assemblea nazionale con grande probabilità si tramuterebbe nell’ennesimo fallimento.
Un Paese rappresentato da forze politiche differenti imporrebbe a queste ultime di trovare dei compromessi, individuare dei punti di caduta. Ad oggi a proposito della riforma delle pensioni, che prevede un progressivo aumento dell’età pensionabile, tale accordo sembra maturo, ma la partita è ancora aperta: il Partito socialista auspica una sospensione della riforma mentre il fronte macronista sarebbe disposto a… ritardarne gli effetti. I due propositi sono analoghi o no? Difficile dirlo.
Insistendo sull’incapacità dei partiti di fare politica, che per definizione è anche pratica del compromesso, non si può tuttavia tacere degli errori del presidente della Repubblica, da ultimo la decisione di non provare mai la carta di un primo ministro di sinistra, a dispetto del fatto che il Partito socialista si sia presentato alle ultime elezioni dentro un’alleanza – il Fronte popolare – in grado di ottenere la maggioranza relativa dell’Assemblea (con poco meno di 200 seggi).
La fatigue démocratique, la sfiducia verso la politica
La crisi politica della Francia si ripercuote inevitabilmente sulla sua economia, oltre che sulla sua capacità di incidere sul complesso scenario internazionale, ma la crisi rischia di delegittimare la cultura democratica del Paese nel suo complesso. Il pericolo, in altri termini, è che si diffondi una sorta di “fatigue” (fatica/stanchezza) nei riguardi della democrazia, della sua prassi. Di «fatigue démocratique», in verità si parla da molti anni (e non solo per il contesto francese), ma il ricorso a questa espressione sta aumentando in maniera significativa in questi mesi.
Proprio per evitare che siano le regole democratiche tout court a essere considerate “anacronistiche”, incapaci di affrontare la situazione di crisi interna e internazionale, i politologi richiamano con sempre maggiore forza l’attenzione dei francesi verso modelli politici quasi interamente centrati sul compromesso (si pensi alla Germania, dove all’indomani delle elezioni le forze di maggioranza siglano un contratto di governo) o verso vicende politiche segnate da lunghi periodi di mediazioni (in Belgio, ad esempio, l’esecutivo è stato varato nel febbraio del 2025 dopo ben 236 giorni di trattative).
Appare così in controtendenza l’intervista uscita nei giorni scorsi su «L’Express» dell’intellettuale Alain Minc che a dispetto dei tanti errori di Macron, si dichiara fiducioso delle sorti della Francia, affermando di non credere che questa finirà per replicare il modello italiano dei “governi balneari” (Alain Minc: “Emmanuel Macron est le pire président de la Ve et j’ose espérer qu’il n’en est pas le fossoyeur”, «L’Express», 9 ottobre 2025, p. 27). Tali esecutivi, costituiti tradizionalmente in estate onde evitare elezioni anticipate, furono una delle soluzioni di compromesso tipiche della cosiddetta prima repubblica italiana e, ad anni di distanza, possono legittimamente essere interpretati come una situazione “fantasiosa”, soprattutto finalizzata alla conservazione del potere (dunque al mantenimento di determinate “poltrone” che contano…). Eppure proprio l’esperienza dei governi balneari ribadisce ancora una volta come la forza della politica talvolta si debba situare nella pratica dei compromessi. Non è per altro inutile ricordare che alcuni di quegli esecutivi riuscirono a durare ben oltre Ferragosto, ci riferiamo al governo Leone e al Rumor II. Quest’ultimo si trovò persino a gestire l’autunno caldo del ’69 nonché le conseguenze dell’attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre di quello stesso anno, un attentato di matrice fascista e dalle evidenti finalità golpiste, come accertato dalla storiografia, finalità poi scongiurate: sfide, dunque, importanti, gestite da un governo che possiamo (e dobbiamo) definire espressione della volontà degli italiani tanto quanto quello odierno guidato da Giorgia Meloni.
Effetto valanga
In Francia, insomma, le difficoltà delle forze politiche (anche quella di Macron, che stenta a ergersi ad attore neutrale di questa contesa) rischiano di produrre un effetto valanga, con la possibilità che essa travolga la Quinta repubblica e, peggio ancora, la fiducia nei riguardi della democrazia nel suo complesso.
Gli effetti potrebbero essere devastanti. Come specificato nell’ultima edizione del rapporto sulla democrazia, realizzato dall’istituto svedese V-Dem, nel 2024 i regimi autocratici presenti sulla scena globale superano in numero le democrazie, confermando una tendenza che si è affermata nell’ultimo decennio. Alimentare questa sorta di “fatica” attorno al meccanismo della democrazia rischia di crescere le tentazioni autocratiche persino in Francia il cui agone politico presenta partiti sulla cui difesa dei valori repubblicani è ancora lecito dubitare.
(Foto di Cecile Hournau su Unsplash)