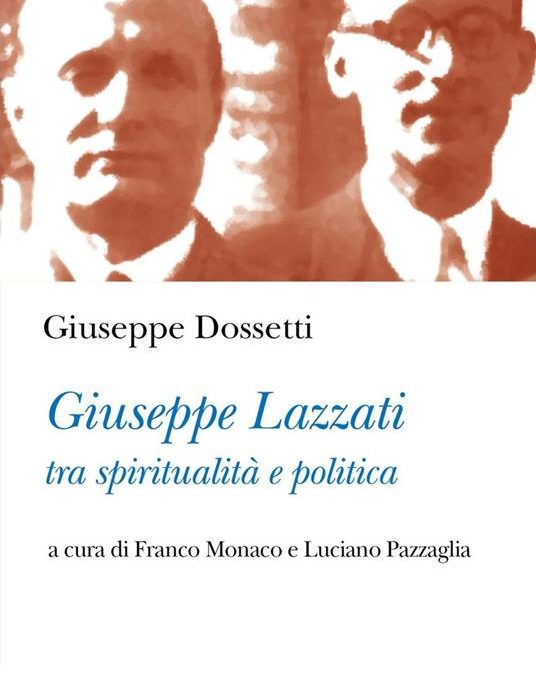Era rimasta nel cassetto (meglio, nel nastro del magnetofono) per trentanove anni. Finalmente (e fortunatamente) ha visto la luce nello scorso mese di luglio l’intervista di Franco Monaco e Luciano Pazzaglia a don Giuseppe Dossetti su Giuseppe Lazzati, registrata il 20 dicembre 1986 a Crespellano (Città metropolitana di Bologna). L’ha pubblicata Scholé, marchio dell’Editrice Morcelliana, nello scorso luglio[1].
Il grande amico dell’intervistato era deceduto a Milano, il precedente 18 maggio. Un’amicizia, la loro, cinquantennale, iniziata nella primavera del 1935 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore. Lazzati vi si era laureato nel 1931 con una tesi in Letteratura cristiana antica. Dossetti, conclusa Giurisprudenza a Bologna, laurea in Diritto canonico, si era iscritto alla Scuola di perfezionamento in Diritto romano presso la Cattolica. Nell’ambito delle sue ricerche ebbe modo di rivolgersi per qualche consiglio al dott. Lazzati, intento ai propri studi nei locali del Seminario di filologia classica, dandogli rispettosamente del “lei”. Usava così fra persone che non si conoscevano e non di pari età: il giovane milanese era del 1909, quello emiliano del 1913.
In tal modo, iniziò una consuetudine che, per breve tempo (1936-’38), li vide affiancati nel comune cammino vocazionale fra i Missionari della Regalità di Cristo, sodalizio di consacrazione laicale, promosso nel 1928 dal rettore della Cattolica, p. Agostino Gemelli. Si trattava di una forma di vita non ancora codificata nell’allora vigente codice di Diritto canonico. Vicissitudini interne ai Missionari, insieme anche a una non convincente distinzione fra vocazione e impegno accademico, indussero i due Giuseppe ad abbandonare quell’esperienza. Incoraggiato dal card. Schuster, arcivescovo di Milano, Lazzati (dal 1934 presidente diocesano della Gioventù di Azione Cattolica) diede vita (1938) al nuovo sodalizio “Milites Christi”. Dossetti proseguì per conto suo, sempre fedele all’opzione celibataria. Ebbene, di tutto ciò si parla nel primo capitoletto del testo: “La Cattolica di Gemelli e l’Azione cattolica di Schuster”.
Nel secondo, “Radicalità cristiana e indole secolare”, Dossetti, incalzato dagli intervistatori, si esprimeva, intanto, sulle radici cultural-spirituali dell’amico. A ragione, rilevava l’influsso della spiritualità ignaziana (già caratterizzante ‒ noto io ‒ l’esperienza giovanile di Giuseppe nell’associazione “Santo Stanislao”), però integrato/temperato dalla cultura dei «grandi padri» della Chiesa, da lui studiati, che gli diede un’«apertura», una «dinamica molto più positiva, più libera» (p. 30). Non trascurabile, poi, l’incidenza della tradizione benedettina dell’«Ora et labora», a Milano incarnata dallo stesso presule.
Ma, di là da questi pur importanti riferimenti, a Dossetti premeva sottolineare un punto qualificante Lazzati: la sua «radicalità [cristiana] sempre molto coerente sul tema della laicità, quello che poi lo ha contraddistinto sino alla fine». L’insistenza circa il suo essere «laico […] per lui significava veramente cristiano fedele». Insomma, per Lazzati, «la laicità non doveva in nessun modo portare ad annacquare il cristianesimo». Al riguardo, egli ‒ concludeva Dossetti ‒ è stato «veramente esemplare» (p. 31).
“Tra fascismo e rinascita democratica” è il titolo del terzo capitoletto. Qui si affrontava un punto significativo anche dei riferimenti culturali di Lazzati: il rapporto con il Maritain di Humanism intégral (1936). Interprete di una visione della relazione del credente con il mondo secondo la classica prospettiva tomistica dei due ordini, “naturale” e “soprannaturale” (“spirituale” e “temporale”), il pensatore francese era indotto a distinguere fra “Azione cattolica e azione politica”, con la conseguente formula dell’agire in quanto e dell’agire da cristiano. Ebbene, Dossetti, non senza avere prima notato che il pensiero maritaniano aveva avuto credito nella più avvertita intellettualità cattolica del tempo, favorendo il guadagno di una doverosa distinzione di piani fra “apostolato” e “politica”, precisava: a livello personale, di essere rimasto convinto per un certo periodo della bontà di quell’impostazione, salvo poi distaccarsene (nell’intervista non indicava le ragioni, ma penso fossero da ascriversi al guadagno di una visione più sintetico-unitaria del problema, maturata dai successivi approfondimenti biblico-teologici e spirituali); quanto all’amico Giuseppe, confermava invece la sua sostanziale fedeltà allo schema (oggi forse, o senza forse ‒ aggiungo sempre io ‒, teologicamente un po’ démodé, ma con il merito, se non altro, di evitare rischi adducenti a “confusioni” dal sapore integristico, come testimonia l’esperienza di alcuni movimenti ecclesiali anche dopo il concilio Vaticano II).
Il terzo capitolo concerne gli incontri riservati di un gruppetto di professori, quasi tutti della Cattolica, in casa di Umberto A. Padovani, tra il 1941 e la primavera del ’43, per riflettere sul futuro del Paese, dopo la guerra. Con Dossetti, principale promotore/animatore, vi parteciparono, non in modo ugualmente assiduo: Lazzati, Amintore Fanfani, Antonio Amorth, Sofia Vanni Rovighi, p. Carlo Giacon, don Carlo Colombo (della Facoltà teologica milanese), Gustavo Bontadini, Giorgio La Pira (dell’Università di Firenze).
Mentre il conflitto mondiale proseguiva sempre più atrocemente, si succedevano le ben note date di eventi che segnarono le tappe di un percorso gravido di speranze, insidie, sofferenze, lotte: 25 luglio ’43, caduta del fascismo; 8 settembre, armistizio con gli anglo-americani; inizio della Resistenza; 23 settembre, Repubblica sociale italiana. Laconicamente, Dossetti osservava: «Fanfani espatriò»; «Lazzati espatriò a modo suo [cioè, fu deportato nei campi di concentramento tedeschi, ndr] e io mi buttai nella lotta clandestina, viaggiavo tra Cavriago e la montagna reggiana» (pp. 58, 59).
Il quarto capitoletto, “Costituente e ‘Cronache sociali’”, è sulla ripresa della vita civile, con il desiderio febbrile di ricostruire il Paese dalle macerie materiali, morali, politico-istituzionali. Di ritorno dalla prigionia, quando pensava di potere finalmente riprendere gli studi e l’attività in Azione cattolica, Lazzati, “suo malgrado”, anche (o principalmente) su sollecitazione dell’amico Dossetti fu «trascinato» in politica, stante il bisogno urgente di figure in grado di rappresentare autorevolmente il mondo cattolico. Furono i formidabili anni di comune esperienza da eletti in parlamento per l’Assemblea Costituente (1946-’48) e, a seguire, quali membri della prima legislatura repubblicana nelle file della Democrazia cristiana.
Come si sa, intorno al parlamentare reggiano si costituì nel settembre ’46 l’associazione di elaborazione culturale-politica “Civitas humana”, promotrice, dall’anno dopo, della rivista “Cronache sociali”. Interpellato dagli intervistatori sul ruolo di Lazzati in ordine a queste iniziative, egli rispondeva: «Un grande ruolo, un ruolo di saggezza. Effettivamente io, quando sapevo che lui era cordialmente consenziente, mi sentivo molto confortato». Poi, con specifico riguardo al periodico aggiungeva: «lui ebbe un ruolo importantissimo. Anche se vi scriveva poco, era sempre un ispiratore e una garanzia» (pp. 65-66). Si aveva conferma di tali giudizi e apprezzamenti a proposito dei “Gruppi Servire”, promossi in varie parti d’Italia, con l’intento di favorire un’opera di formazione politica, specialmente fra i giovani. Riguardo a questa iniziativa, noto in parentesi che il presidente Cossiga ebbe modo di ricordare con favore l’occasione dell’incontro, da giovane, nella sua Sassari, con Lazzati (Un Maestro che abbiamo amato, in Testimonianze su Giuseppe Dossetti, In Dialogo, Milano 1986, pp. 9-10). Ebbene, Dossetti precisava che proprio per tali gruppi l’amico Giuseppe «ebbe una grande importanza. Perché lui parlava bene, aveva fascino» (p. 67). Non v’era da sorprendersi. Il carisma educativo costituiva tratto saliente della personalità di Lazzati. E l’esperienza alla guida dei giovani ambrosiani di Azione cattolica ne aveva data ampia conferma.
Chiudevano il capitolo domande e risposte sui loro non semplici rapporti con De Gasperi, sul patto atlantico (Lazzati quasi a “trascinare” in aula il riluttante amico per votare l’adesione), sulla compattezza o meno della loro “corrente” (Dossetti sottoscriveva la battuta lazzatiana secondo la quale i veri dossettiani erano solo loro due: cfr. p. 76).
Il quinto e ultimo capitoletto dell’intervista s’intitola “La ‘Città dell’uomo’”. Poche pagine, con veloci scambi relativi a qualche tassello dei molto diversi percorsi di vita dopo la comune militanza parlamentare (in parte coincisa anche con un altro pezzo di strada condivisa ‒ 1950-’55 ‒ nell’Istituto secolare “Cristo Re”, presieduto da Lazzati). Dossetti ebbe ancora un periodo d’impegno politico-amministrativo a livello bolognese (1956-’58), poi lo sviluppo del cammino di una vocazione approdata al sacerdozio diocesano (durante l’episcopato di Lercaro), quindi alla vita religioso-monastica (fondazione della Piccola famiglia dell’Annunziata, con lunghe permanenze, da inizio anni Settanta, in Palestina). Lazzati tornava all’insegnamento universitario, “inseguito” da incarichi, ecclesiali e non, soprattutto a livello ambrosiano (fra questi la direzione del quotidiano “L’Italia”, 1961-’64, in obbedienza alla richiesta rivoltagli dall’arcivescovo Montini), sino al servizio culmine della sua laboriosa giornata terrena: il quindicennio di rettorato dell’Università Cattolica (1968-’83) (giudicato dal prof. Bontadini come «il vertice» del suo impegno per la cultura, i giovani, la Chiesa, la società: La pienezza della santità, in Giuseppe Lazzati testimone e maestro di laicità cristiana, In Dialogo, Milano 1987, p. 44).
Evento periodizzante per entrambi il concilio Vaticano II. Le preoccupazioni di Lazzati sulla persistente “im-maturità” del laicato cattolico, per cui ravvisava l’urgente necessità di un’opera formativa ampia e profonda. Con l’amico Dossetti a condividere sostanzialmente l’analisi, anzi, per certi versi aggravandola: non per nulla, a precisa domanda egli rispondeva parlando del «deterioramento del modo di pensare […] anche dei pastori: per l’approssimazione, per l’ottusità con cui guardavano le cose» (p. 84).
La preoccupazione per un’autentica “maturità” dei laici, che significava anche crescita in consapevolezza politica, cioè di responsabilità verso la pólis, la città di tutti, democratica e plurale, indusse Lazzati a promuovere nel 1985, insieme ad altri amici, l’associazione “La Città dell’uomo”, che già nel titolo esprimeva una sorta d’ideale collegamento con la suddetta “Civitas humana”. Dossetti non si meravigliava di quest’ultima iniziativa, espressione di un «interesse civile» mai dismesso e «logica conseguenza della sua posizione laicale» (p. 86). Ricordava pure d’essere stato invitato dall’amico a impegnarsi per “La Città dell’uomo” (cfr. p. 80). A suo modo, don Giuseppe, una volta rientrato in Italia dal Medio Oriente, anche per motivi di salute (1982), finì con lo svolgere, tramite selezionati interventi pubblici, un’incisiva opera di coscientizzazione spirituale-civile, d’indubbia, ancorché indiretta, rilevanza propriamente politica. Era intesa a favorire, per un verso, il risveglio della cattolicità italiana dai troppi “assopimenti” e “sonnambulismi” dinanzi ai cambiamenti in corso, per un altro verso a porre in guardia l’intera comunità nazionale dai programmi delle “destre” di stravolgimento della Carta costituzionale.
Tre mesi prima della scomparsa, Giuseppe Lazzati ricevette dal comune di Bologna l’invito per l’intervento ufficiale sulla figura di Giuseppe Dossetti in occasione del conferimento (22 febbraio 1986) del prestigioso riconoscimento dell’Archiginnasio d’oro della città. Benché febbricitante per l’ormai fatale decorso del male che lo affliggeva, onorò tale invito, confermando un idem sentire cattolico-democratico con l’amico, pur nella differenza dei cammini vocazionali.
Da parte sua, Dossetti rese testimonianza sul “servo di Dio” Giuseppe Lazzati il 9 novembre 1992 e il 30 marzo ’93, nel corso del processo informativo diocesano di Milano relativo alla vita e alle “virtù eroiche” di lui.
Il volumetto di cui ci occupiamo reca in “Appendice” l’intervento integrale. È stata scelta felice dei curatori. Alle minuziose domande del Delegato arcivescovile per la Commissione diocesana d’inchiesta, Dossetti rispose sempre con precisione, contando sulla sua proverbiale, lucida memoria.
Venne passata in rassegna la vita del “servo di Dio”, considerata dal punto di vista dell’interesse per la “Causa”, che implicava l’esame di parole, scritti, stili, comportamenti coerenti con l’esercizio “eroico” delle fondamentali virtù cardinali e teologali. Parecchi passaggi ricalcavano quanto detto nell’intervista del 1986. Bastino due brani per restituire il “tono” della deposizione di Dossetti.
L’ultima domanda formulatagli era la seguente: «Lei ritiene opportuna una causa di canonizzazione?». Ecco la risposta: «Posso dire che complessivamente [quella di Lazzati, ndr] mi è sembrata una personalità cristiana molto equilibrata e molto fondata nell’autentico cristianesimo, come lo penso io, e molto concreta senza nessuna mancanza di questa integralità e insieme di questa misura e armonia. Se questo è un santo, credo di sì, che la Causa di Lazzati sia opportuna» (p. 132).
Ma, il passo più toccante della testimonianza mi sembra quello nel quale Dossetti rammenta la visita, con il fratello Ermanno, all’amico in clinica sabato mattina, 17 maggio 1986, vigilia di Pentecoste. La situazione non sembrava dovesse precipitare da un momento all’altro, tant’è che egli si riprometteva di tornare a far visita all’amico. Invece lo stato di salute si aggravò repentinamente e Lazzati spirava all’alba del 18.
La scena, che ci riporta ad atmosfere spirituali di condivisa partecipazione al Mistero di grazia e di fede, proprie del cristianesimo delle origini, era così descritta da Dossetti: «Ci si scambiò alcune parole intense, ci scambiammo la benedizione, pregammo insieme con la consapevolezza che la fine non era immediata, ma molto prossima» (p. 121).
Amici, Padri costituenti (e tante altre cose in comune)… ma soprattutto cristiani veri!
[1] G. Dossetti, Giuseppe Lazzati tra spiritualità e politica, a cura di F. Monaco e L. Pazzaglia, Scholé, Brescia 2025.
Crediti foto: copertina del libro